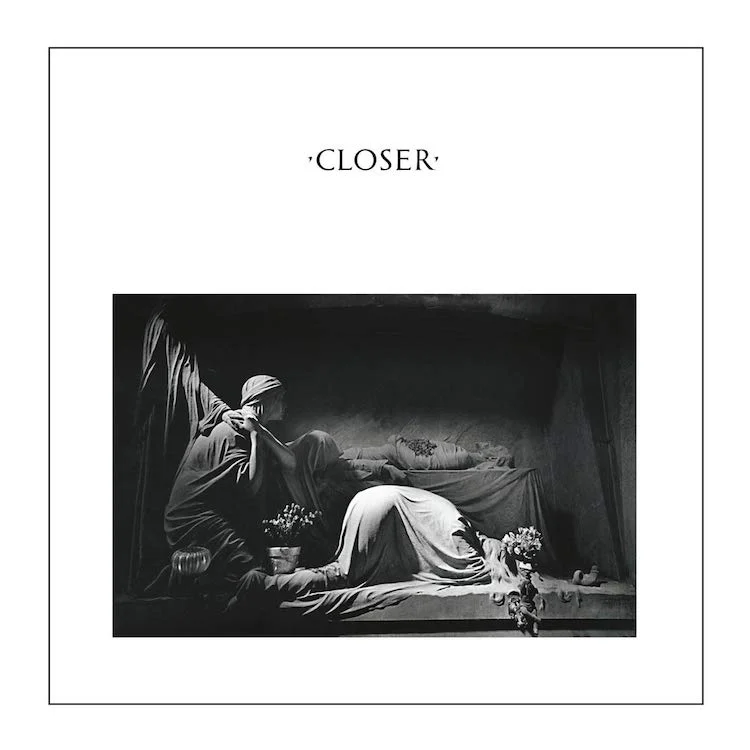
La puntina scorre lungo i solchi di “The Idiot” di Iggy Pop. “Stroszek” di Werner Herzog ha da poco mandato i suoi titoli di coda. Ian Curtis si sposta nella cucina della sua casa di Macclesfield, nel Cheshire, scrive qualche riga indirizzata alla moglie Deborah e poi il buio, pone definitivamente fine alle sofferenze che non gli davano tregua, quelle fisiche e quelle di una mente arrovellata su se stessa. Impiccandosi. Era il 18 Maggio del 1980, Ian non aveva neanche ventiquattro anni e nessuno di coloro che lo conoscevano davvero poteva rimanere sorpreso da un tale epilogo, il suo patire era diventato infernale, insopportabile, l’epilessia che lo tormentava, i sensi di colpa nei confronti di Deborah, il guscio di solitudine in cui s’era sepolto, le difficoltà sempre più insistenti riscontrate nell’unica cosa − scrivere i testi delle sue canzoni − che fungeva almeno un po’ da pallido placebo per una condizione a dir poco precaria. La morte, un’amante con cui Ian flirtava da sempre, di cui non si spaventava a parlare e che alla fine l’ha fatto prematuramente suo.
Esattamente due mesi dopo l’atto finale della vita di Curtis esce Closer, l’album su cui tra pochi alti e un’infinità di bassi Ian e i Joy Division avevano iniziato a lavorare già subito dopo l’uscita di “Unknown Pleasures” (1979). Ed è un testamento il secondo e ultimo lavoro della formazione inglese, non soltanto perché banalmente uscito a ridosso della morte di Curtis, ma piuttosto per il ritratto incredibilmente coerente alla realtà e tristemente lucido dei demoni di un uomo, un ragazzo afflitto senza un’apparente via d’uscita. Una via d’uscita che, anche ci fosse stata, Ian stesso aveva deciso di rendere definitiva, ben prima di quell’angosciante giorno di metà Maggio.
È soffocante “Closer”, è un lago nero e denso come la pece da cui emerge un Ian Curtis tremendamente ispirato nel descrivere la sua disillusione verso il mondo e le persone fuori dal suo guscio (Atrocity Exhibition), il suo isolamento malsano che lo fa vergognare della persona che è diventato o che forse è sempre stato (Isolation), il suo chiedersi cosa potrà mai riservargli un inquietante e inevitabile “dopo” (Passover, il trapasso ormai inequivocabilmente prossimo); e ancora lacerante solitudine (Colony), pagine e pagine di rimpianti (A Means To An End) e poi immaginare come sarebbe stata la sua stessa cerimonia funebre (The Eternal), fino alla lunga e lugubre marcia verso un qualcosa che da spettro diventa tangibile realtà (Decades).
È soffocante “Closer”, perché Curtis non nasconde neanche un grammo del macigno che incombe sulla sua anima, ma anche perché rispetto ad “Unknown Pleasures” i Joy Division si fanno qui per mano del produttore Martin Hannett ancora più minimali, più riverberati, più compassati, robotici, sintetici, marziali, accompagnando e acuendo a dismisura il senso definitivo delle parole di Ian. Stephen Morris e Peter Hook mettono in piedi una delle sezioni ritmiche che più hanno segnato la storia della musica che da lì in poi sarebbe venuta, mentre la chitarra di Bernard Sumner − spesso ben più in evidenza della stessa voce baritonale e profonda di Curtis − è una lama che a tratti sembra infierire sulla sofferenza di Ian. Una sofferenza senza fine che “Closer” impone con violenza.