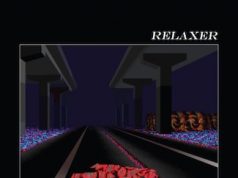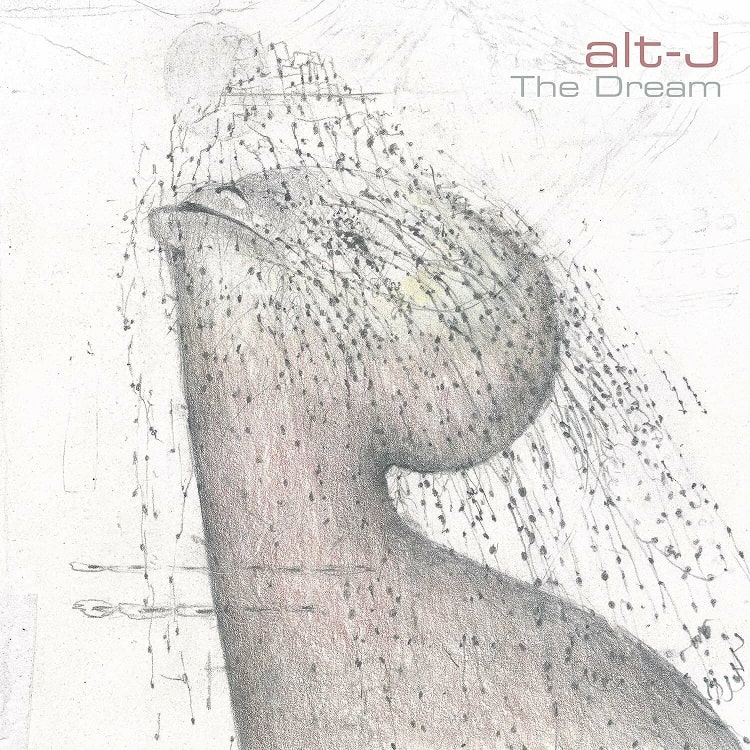
Chi l’ha detto che per rinnovarsi sia sempre necessaria una rivoluzione? C’è chi ha basato un’intera carriera sul trasformismo, una muta dopo l’altra per stare dietro ai tempi che corrono, poi c’è chi ci ha provato, senza mai riuscire a trovare la pelle giusta in cui stare, e c’è chi ha preferito non abbandonare mai la propria comfort zone creativa. Poi esiste una quarta categoria, quella di chi ha scelto la naturalità dell’evoluzione. Di quelli che sembrano non cambiare mai, mentre tessono silenziosamente, di lavoro in lavoro, una trama sempre più fitta dalla loro matassa. Quelli che sperimentano tra generi, parole, strumenti sempre nuovi, senza stravolgere la matrice. Quelli come gli alt-J.
Nel caso della band inglese, parte di questo strano fenomeno per cui ogni volta i loro album risultano quasi “prevedibili”, è sicuramente da imputare alla voce unica e riconoscibile di Joe Newman, che rappresenta uno dei fili intrecciati della loro tela, quello rosso, per la precisione. L’altro filo è da cercare nei testi, nei ritratti di personaggi, storici o cinematografici, che gli alt-J usano da sempre come muse ispiratrici per trasmettere messaggi e allegorie. Ne è un esempio lampante “Matilda”, incentrata sulla protagonista del film di Luc Besson, Léon, o ancora “Taro”, che racconta della fotografa di guerra Gerda Taro e del suo compagno Robert Capa. Una firma che dona ai brani ancora più prestigio e li rende delle piccole perle di conoscenza.
Oggi, a dieci anni dal debutto discografico con “An Awesome Wave” (2012), gli alt-J sfornano il loro quarto album, e questo filo continua a serpeggiare tra le composizioni. Anche The Dream, infatti, ci regala interessanti riferimenti alla cultura pop; a partire dalla risposta alla celebre “Hey Joe” di Jimi Hendrix, data attraverso Happier When You’re Gone, nella quale raccontano per la prima volta il punto di vista della vittima di Joe, stanca dei continui abusi e dell’inferno vissuto ogni giorno nella sua stessa casa. In The Actor, invece, gli alt-J fanno esplicitamente riferimento alla morte di John Belushi, avvenuta nel 1982 nell’hotel Chateau Marmont a causa della sua dipendenza dalle droghe. Una vicenda nella quale riusciamo a immergerci anche grazie al contesto anni ’80 creato dall’arpeggio di un synth che dà corpo alla melodia.
La morte viziosa di The Artist, si contrappone a quella privatamente dolorosa di Get Better. Un soffio leggero, una piuma che diventa macigno una volta ascoltate attentamente le sue parole. Una canzone struggente non solo perché parla della perdita di una compagna di vita, ma soprattutto per i piccoli momenti raccontati. Nei propri testi gli alt-J cercano di trasporre, tra una marea di situazioni ordinarie, dei dettagli irripetibili. Per questo arriviamo quasi a conoscere i due protagonisti, a spiare dalla serratura della loro intimità emotiva. Scopriamo una passione comune per Elliot Smith, un paio di registrazioni ascoltate e riascoltate per ingannare il dolore, l’unicità di una relazione che è stata brutalmente spazzata via.
Ad ogni modo “The Dream” è un disco lunatico, imprevedibile, caratterizzato dalla capacità di passare da temi intensi e crudi a realtà adolescenziali e feromoniche, come quelle di U&ME, al profumo di salsedine e fulminee cotte estive, o Hard Drive Gold, che parla di un quindicenne diventato milionario grazie alle cryptovalute, fino a Powder, un sogno a occhi aperti, che chiude l’album con una nota positiva. Ma il vero cuore pulsante delle sperimentazioni creative ci aspetta altrove. In brani come Bane, ispirato da uno strano sogno, un’allucinazione mixata al racconto di una dipendenza da Coca Cola. Un pezzo dal tema assurdo, introdotto da un coro solenne che, passando per brevi reminiscenze dei Beatles più onirici, sfocia in sonorità trip hop. Un brano musicalmente dicotomico, e assolutamente non l’unico di “The Dream”, che gioca spesso su queste dualità tra generi. Walk A Mile, ad esempio, parte con un quartetto vocale a cappella formato da Joe, Gus Unger-Hamilton e due loro ex compagni di scuola, per poi svelarci una fisionomia a tratti soul.
Il brano successivo, Delta, invece è una laconica preghiera che traghetta dritti verso l’oscurità di Losing My Mind, un viaggio nelle menti di un serial killer di bambini e del padre di una delle sue vittime. Due uomini persi, a causa di due angolazioni diverse della medesima vicenda. Le loro voci vengono interpretate da cori che pronunciano le stesse parole, “You and I, cut from the same cloth”, con il risultato di un duetto armonioso e allo stesso tempo dissonante. L’apice del climax sperimentale dell’album porta i nomi di due città. Chicago, nata nell’omonima metropoli durante un fortunato soundcheck. Pezzo schizofrenico, con un falsetto leggero, strattonato tra una chitarra arpeggiata ed elementi di musica house.
E infine Philadelphia, la punta di diamante. La cantante lirica Christie Valeriano, un clavicembalo e degli archi incontrano il pop, con il risultato di un pezzo barocco, visionario, illuminante. La testimonianza definitiva di come la band sia riuscita a compiere ancora una volta l’evoluzione, grazie al suo coraggio compositivo e a un’instancabile ricerca sonora. Strati su strati, tra effetti, registrazioni casalinghe, accostamenti non canonici, quasi improbabili. Il loro personale intreccio. Un bozzolo, ancora una volta, perfetto.
(2022, Infectious)
01 Bane
02 U&ME
03 Hard Drive Gold
04 Happier When You’re Gone
05 The Actor
06 Get Better
07 Chicago
08 Philadelphia
09 Walk A Mile
10 Delta
11 Losing My Mind
12 Powders
IN BREVE: 4/5