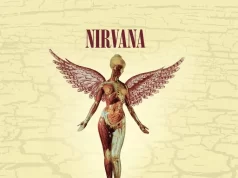Applausi. Urla. Kurt che sibila: “Good evening. This is off our first record, most people don’t own it”. E poi About A Girl col suo giro di acustica profondo come un sospiro. Questo attacco lo abbiamo ascoltato migliaia di volte. Lo abbiamo ripetuto storpiandone le parole. Come una poesia che ripassi a memoria. E che sbagli e ricominci. Sempre quel applausi-urla-Kurt-About a girl. Come la scena di un film che conosci bene e di cui anticipi le battute. Come il gusto preferito di gelato del tuo migliore amico. Lo conosci, lo prevedi. Ma nonostante tutto, ogni volta, quando parte l’MTV Unplugged In New York, ti senti spintonato all’indietro. Un capitombolo con la sedia. Una prima volta. Ti ricomponi, senti i lividi, ti tocchi la faccia, ritrovi la freschezza dei lineamenti che non hai più e quella di capelli che odorano di sciampo per adolescenti. Reset. Si ricomincia.
L’Unplugged nella discografia dei Nirvana è molto di più di un live. Tutte le band hanno pubblicato album dal vivo nella propria carriera, ma quel concerto è qualcosa di diverso: a tutti gli effetti il quarto disco della band. Come un lavoro in studio, come la naturale evoluzione del gruppo. Il livore di “In Utero” che diventa sconforto, stasi. La rabbia che si fa magone. La maglietta sdrucita sostituita da un vecchio maglioncino color pastello (lo indossa Cobain in barba alla moda grunge). Le canzoni, pure quelle più taglienti e muscolari, portate ad un miracoloso livello di essenzialità. Kurt è morbido nei movimenti, seduto comodamente nella sua seggiola roteante da ufficio. Ai suoi piedi e tutt’attorno candele, lumini e fiori freschi. La penombra è resa perfettamente dalla crew di MTV con un lampadario stile antico e alcune luci violacee: una triangolazione che si riflette sulle tende in caduta sullo stage. Il pubblico è selezionato, se ne scorgono le teste more nel perimetro del palco. Dave Grohl veste un lupetto nero con un elastico fucsia a tenergli a bada il codino. Krist Novoselic, in polo, maneggia un’enorme acustica castana. E poi c’è Pat Smear appollaiato s’una chitarra dai colori africani e Lori Goldston al violoncello. Le canzoni scivolano, ogni tanto Kurt scherza con certi ghigni tra i denti e quella voce che è un inno alla disperazione: meravigliosamente bigia, luccicante di nero.
Quando si parla dell’Unplugged In New York il cruccio è sempre lo stesso: chissà cosa avrebbero potuto fare i Nirvana senza la tragedia dell’Aprile 1994. Come sarebbero invecchiati, come avrebbero raccontato la propria trasformazione da ragazzi a uomini. L’Unplugged sembrò suggerirlo. Il senzaspine di New York sembrò un abito perfetto per i Nirvana in un momento storico in cui prevaleva in loro, per la verità, un certo smarrimento, tra il panico di una fine imminente e una carriera osteggiata da molti.
A un certo punto dell’esibizione, quando arriva il momento di On A Plain, Kurt si prende del tempo, chiede più voce ai tecnici, poi va: “Il miglior giorno che abbia mai avuto – stride la voce tra lingua e palato – è quando ho imparato a piangere a comando”. Kurt è calmo, i lamenti che emette passano attraverso le feritoie strette delle labbra. Il suo volto è ieratico. I capelli biondi penzolano come foglie di salici piangenti. Cobain sta piangendo ma non piange. Si trova in quella fase in cui, se si scoperchiasse il tetto del teatro e un ciclone facesse razzia di tutto, lui continuerebbe a suonare senza batter ciglio. Infatti in Dumb, mentre conficca il suo cantato in un tubo metallico, e ulula il famoso “Non sono come loro ma posso fingere, credo di essere stupido o forse sono semplicemente felice”, sembra quasi in pace. Una pace che fino a quel momento non ha mai avuto nella sua intera vita. E che pare fittizia, imposta, surreale, quasi una quiete prima della tempesta, un caos calmo. Anche in Oh Me – nel frattempo sul palco sono saliti i Meat Puppets con le loro flanelle colorate e dal cilindro Kurt ha delicatamente tirato fuori la frase “I can’t see the end of me” (“Non posso vedere la mia fine”) – il fatalismo di quel momento appare chiaro e istantaneo come una polaroid ancora calda.
È il 18 Novembre del 1993 quando i Nirvana registrano questo magnifico concerto privo di elettricità. Un anno dopo, l’1 Novembre 1994, il giorno in cui viene pubblicato il disco, Kurt è già morto. Nel mezzo, l’occhio di un ciclone, la messa in scena della disperazione di un uomo. L’incoscienza di un ragazzo così fragile ma così potente nel colpire le corde di tutti. Collassi, titoli di giornali, corsie di ospedali, palchi da calcare. E da abbandonare. Un requiem. Un anno all’inferno prima dell’inferno.
Oggi, a venticinque anni di distanza, l’Unplugged In New York resta il testamento di un figlio del suo tempo. Tempo fatto di pioggia acida e ragazzi dall’argento vivo cucito addosso. Nessun eroe, nessuna vittima, nessun martire, per carità. Ma il volto vero però di una generazione senza filtri né color correction. L’Unplugged termina con un applauso lunghissimo e una diffusa commozione, poco prima però è portato alla conclusione da un capolavoro di quasi cinque minuti chiamato Where Did You Sleep Last Night, canzone anni ‘30 del bluesman Lead Belly che Cobain trasforma da parabola di protesta impolverata di terra e fango a urlo definitivo di un lupo ferito, sanguinante, disperato. A un certo punto, al minuto 2.37, Kurt chiude gli occhi, corruccia leggermente la fronte e blocca il cuore. “Ragazza mia, dove andrai?– oscilla il lampadario – Sto andando dove il freddo soffia, lì sotto i pini, dove il sole non splende mai”, quindi parte l’urlo più abissale che il mondo della musica ricordi, scende una pioggia ghiacciata, s’inoltra un penetrante odore di bosco. E tutto finisce lì. Senza più Kurt, senza più i Nirvana. A restare siamo noi. Con quegli applausi. Lunghi. Venticinque anno dopo. Lì, sotto i pini. Dove il sole non splende mai.
DATA D’USCITA: 1 Novembre 1994
ETICHETTA: Geffen