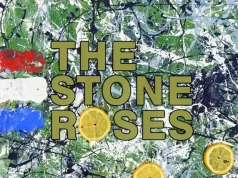Non è che venticinque anni or sono – cioè quando Jeff Mangum compone, registra e assembla In The Aeroplane Over The Sea coi Neutral Milk Hotel – lui non volesse scrivere un capolavoro. Leggenda narra, anzi, della completa devozione all’opera, degli scontri con la band e col produttore, Robert Schneider, alla ricerca del suono ideale, della mistione perfetta, del matrimonio da sogno. È solo che non aveva considerato, Jeff, l’ipotesi che quel disco – un suo disco – potesse avere un seguito, per così dire, reale. Reduce dalle cinquemila copie scarse del primo “On Avery Island” (1996), d’altronde, non era il solo. Sia chiaro: sarebbe fuorviante immaginare che, d’improvviso, la band di Ruston, LA, avesse raggiunto la notorietà dei Radiohead, dopo la pubblicazione. Eppure quel poco era già tanto, già troppo. Il tour andato bene, le vendite discrete, gli R.E.M. che li scelgono come opening act per i loro concerti. Troppo. Così senza un comunicato, senza un’ufficialità, apparentemente senza un motivo: nel 1999, dei Neutral Milk Hotel si perdono completamente le tracce.
Più tardi, in assenza di interviste e con il mito del gruppo in costante aumento, l’amico Bill Doss degli Olivia Tremor Control rivelerà: “Jeff è una persona estremamente privata. I ragazzini cominciarono a seguirlo, chiedere autografi… Questa cosa lo stranì e gli venne naturale fare un passo indietro”. Facciamolo anche noi, un passo indietro. È il 1997 e il cantautore, già ventisettenne, resta completamente folgorato dalla lettura del Diario di Anne Frank – come un semiadolescente qualsiasi. Persino gli amici, all’epoca, trovano la cosa benevolmente puerile. Lui invece – sempre Jeff – trae dall’incontro la linfa lirica necessaria per la stesura del suo prossimo LP, tessendo un fil rouge da se stesso alla sfortunata ragazza ebrea, dalla sua generazione alla Storia, dall’immaginario al fisico, tangibile, violentemente vero.
Con King Of Carrot Flowers (Pt. 1 e poi Pts. 2 & 3), questo sogno trova finalmente corpo. L’avvio del sophomore è di quelli di cui ci si innamora subito e facilmente: folk sporco arricchito da una melanconica cornamusa, che evolve quasi in gospel per sfociare in una sorta di brass-fuzz-noise apparentemente senza padrone. Con la title track si torna immediatamente su binari più classici, con la tromba a stagliarsi come protagonista assoluta e già pronta a far scuola.
Fino ad ora, dopotutto, abbiamo parlato (e a ben donde, ci mancherebbe) soltanto del deus ex machina Mangum. Ma sarebbe sacrilego non sottolineare l’apporto della formazione fissa dei NMH, che ha saputo non soltanto (e)seguire magistralmente le linee guida di un visionario, ma anche ardere insieme a quei brani così personali. Il primo da menzionare è senz’altro Scott Spillane, i cui fiati non solo caratterizzano inopinatamente il lavoro intero, ma anche generazioni di musicisti a seguire. Poi Jeremy Barnes: l’unico, in realtà, a continuare significativamente la propria carriera, dando vita agli A Hawk And A Hacksaw. Infine Julian Koster, lo spirito brass del lotto, indispensabile a creare l’amalgama all’interno di una tale ricchezza espressiva. Ma andiamo avanti.
L’epopea del disco va districandosi con la prima parte di Two-Headed Boy, percorrendo poi il sentiero funerario della dolente The Fool sino all’incontro con la meravigliosa Holland, 1945: il più disperatamente brillante ed esaltante omaggio del Nostro alla Sua, Anne (“The only girl I’ve ever loved / Was born with roses in her eyes / But then they buried her alive / One evening 1945 /With just her sister at her side”). È poi il turno dell’esile e splendida Communist Daughter, che cede il passo ai densissimi otto minuti di Oh Comely: uno stream of consciousness pretestuosamente abbozzato al termine del quale si sente anche qualcuno, in sala, urlare: “Holy Shit!”. Le accelerazioni di Ghost e [untitled], pronte a farsi largo alle sue calcagna, sono le ultime a disposizione dell’ascoltatore – si chiude con Two-Headed Boy Pt. 2, puro Mangum-pensiero tradotto in musica: “God is a place where some holy spectacle lies / When we break, we’ll wait for our miracle / God is a place you will wait for the rest of your life”.
Come già raccontato in apertura, “In The Aeroplane Over The Sea” rappresenterà l’ultimo respiro discografico per una formazione fino ad allora praticamente sconosciuta e dopo allora, negli anni, portata in gloria e supplicata sino agli insulti, non sporadici, nei confronti di un artista geniale e fragile, vittima per tanti di un certo Salinger-ismo. Nel 2002, lo stesso rivelerà a Pitchfork: “Avevo quest’idea – che se avessimo forgiato tutti il nostro sogno, saremmo vissuti per sempre felici e contenti. Quando molte delle nostre aspirazioni presero forma, ma nonostante ciò i miei amici continuarono ad essere infelici, vidi la cosa da una prospettiva differente. Capii che non avrei potuto semplicemente cantare, per trovare una via d’uscita dal dolore”. Ognuno cerca a proprio modo di non morire nel labirinto. Bizzarro, però. Bizzarro come la voce di uno che rinuncia a cantare possa essere invece, per migliaia di altri, la luce da ascoltare per salvarsi.
Nota a margine: la parabola di Jeff Mangum lo vedrà fronteggiare anni di paranoia, dal timore del millennium bug a un isolamento tendenzialmente misantropico. Abbraccerà, come studioso e discografico, specificatamente la musica bulgara, prima di tornare ogni tanto sul palco per se stesso e per pochi, eletti amici. Nel 2014 la reunion dei Neutral Milk Hotel esaudirà finalmente un desiderio a lungo soppresso. Oggi vive a New York dove – pare – sia finalmente felice di scrivere nuova musica. Se verrà mai diffusa, al momento, non è dato saperlo.